Direttiva “Stop the Clock”: quali saranno i prossimi passi e cosa devono fare le imprese italiane
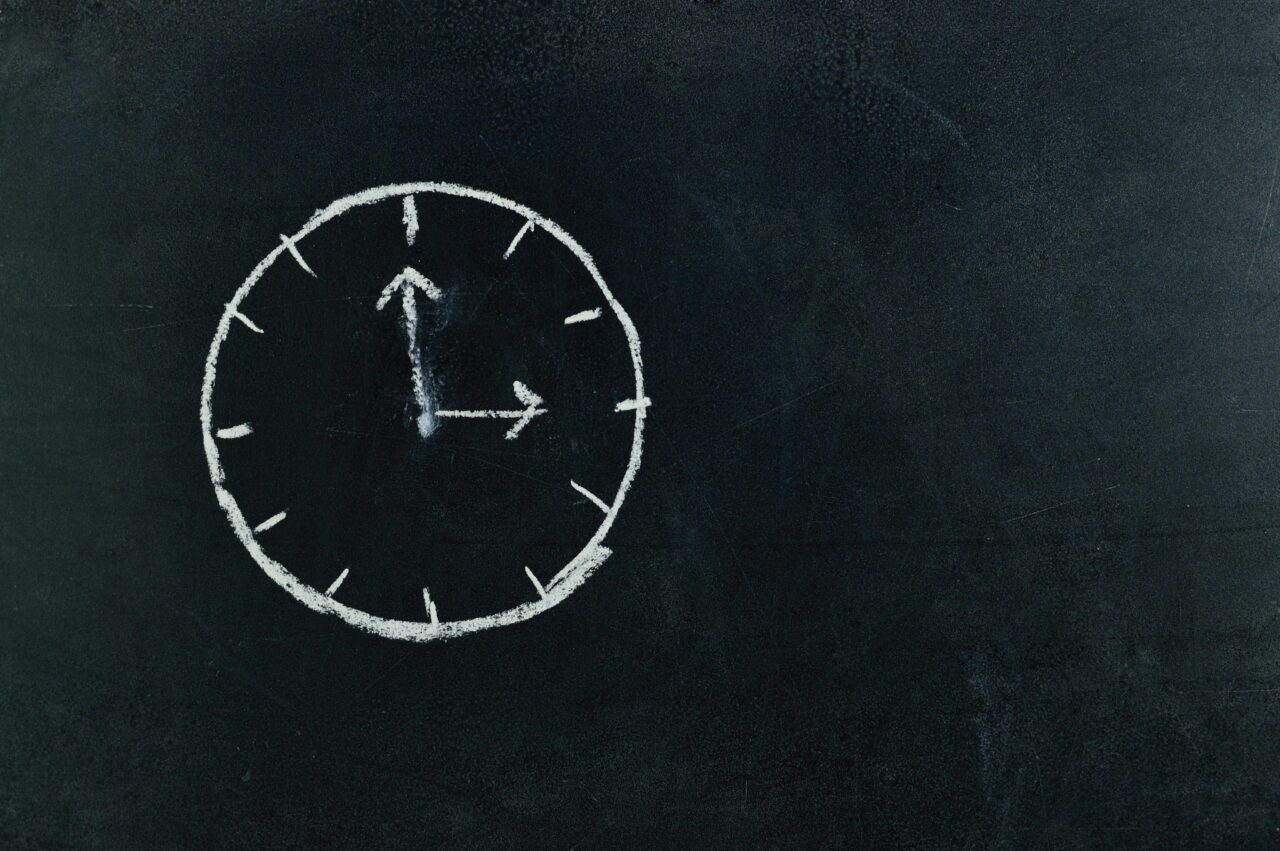
Nei prossimi mesi l’attenzione delle imprese europee sarà tutta concentrata sui passaggi attuativi della Direttiva “Stop the Clock” (Direttiva UE 2025/794), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 16 aprile 2025 e approvata in via definitiva dal Consiglio dell’Unione Europea.
L’obiettivo del provvedimento è quello di concedere più tempo alle imprese per adeguarsi ai nuovi obblighi previsti dalla CSRD e dalla CSDDD, garantendo al contempo maggiore certezza giuridica e riducendo la pressione burocratica sul tessuto imprenditoriale europeo.

I prossimi passi per l’attuazione della direttiva Stop the Clock
Gli Stati membri avranno tempo fino al 31 dicembre 2025 per recepire la Direttiva e adottare le disposizioni necessarie. In Italia sarà quindi necessario modificare il Decreto Legislativo 6 settembre 2024, n. 125 che ha recepito la CSRD, mentre per la CSDDD il termine slitta al 26 luglio 2027.
In parallelo continuerà l’iter della seconda proposta inclusa nel pacchetto Omnibus I, ossia quella relativa alle modifiche sostanziali agli obblighi di reporting e di due diligence.
A differenza della Stop the Clock, questa proposta non beneficerà della procedura d’urgenza e seguirà quindi il normale percorso legislativo europeo.
Ciò significa che le imprese dovranno monitorare attentamente le evoluzioni normative durante tutto il 2025 e il 2026.
Direttiva Stop the Clock: le principali modifiche introdotte
Nel merito, la Direttiva Stop the Clock interviene sui seguenti aspetti:
- modifica l'art. 5, par. 2 della CSRD, rinviando di due anni l’entrata in vigore degli obblighi di rendicontazione per le grandi imprese non ancora soggette alla rendicontazione e per le PMI quotate;
- modifica l’art. 37, par. 1 della CSDDD, posticipando di un anno il termine per il recepimento da parte degli Stati membri e l’inizio della prima fase applicativa per le imprese di maggiori dimensioni.

Questa proroga, tuttavia, non comporta un allentamento dell’attenzione sui temi ESG, che restano centrali nel quadro regolatorio e finanziario della UE.
Il ruolo crescente dei fattori ESG
Le recenti iniziative normative hanno confermato che i criteri ambientali, sociali e di governance continueranno a guidare le politiche di investimento e le decisioni di credito delle banche.
Le nuove Linee Guida dell’EBA, che entreranno in vigore nel 2026 per gli istituti più grandi e nel 2027 per le banche di dimensioni più contenute, richiedono l’inserimento formale dei rischi ESG nei processi di valutazione del merito creditizio.
Per questo motivo le imprese saranno chiamate a fornire informazioni ESG sempre più precise e aggiornate. Il dato ESG diventerà un elemento determinante per accedere al credito in condizioni favorevoli e per preservare la propria competitività sul mercato.

L’importanza della rendicontazione volontaria
Nell’attuale fase di transizione assume quindi grande rilievo la rendicontazione volontaria, soprattutto per PMI e microimprese.
L’introduzione dello standard ESRS VSME da parte dell’EFRAG rappresenta uno strumento prezioso per avvicinare le piccole realtà imprenditoriali alle logiche ESG e facilitare un’adozione graduale e sostenibile delle nuove regole.
Le imprese che si muoveranno per tempo potranno trasformare la compliance normativa in un’opportunità concreta di posizionamento strategico, anticipando gli effetti dell’entrata in vigore della normativa e migliorando i rapporti con investitori, banche e stakeholder.